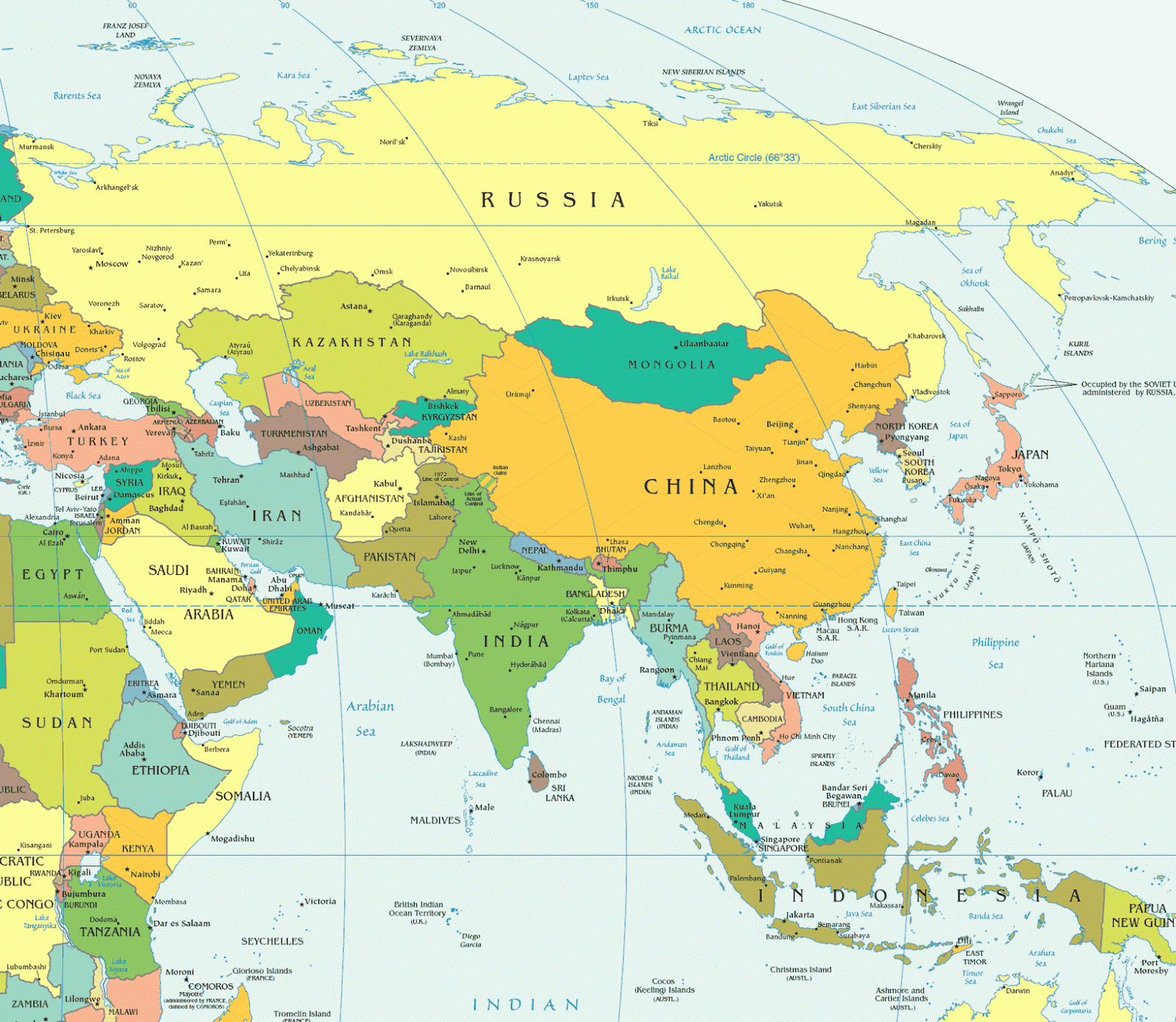Un compleanno non troppo felice per gli abitanti di Hong Kong, quello celebrato il 1° luglio scorso, a vent’anni dal ritorno dell’ex colonia britannica alla Cina continentale. In una città divisa tra sostenitori dell’indipendenza e della democrazia – che ancora rimpiangono le manifestazioni di piazza della rivoluzione degli ombrelli del 2014 -, e nazionalisti – quegli hongkonghesi che rivendicano con orgoglio la loro “cinesità” -, è stato accolto l’ospite d’onore: il presidente cinese Xi Jinping. L’anniversario, inoltre, ha offerto anche l’occasione per l’insediamento della nuova
chief executive Carrie Lam, la filo cinese che ha ottenuto il comando dell’esecutivo della città lo scorso
marzo.
Ingenti misure di sicurezza sono state applicate per la tre giorni della visita del leader della Repubblica popolare: per proteggere Xi e assicurare un clima di “festa” sono scese in campo oltre 11.000 forze dell’ordine hongkonghesi.
Nelle arterie della città si è respirata un’aria pesante e tesa. Da mesi, infatti, gli indipendentisti avevano promosso manifestazioni in segno di protesta contro il governo di Pechino e il nuovo ordine politico configuratosi con la recente vittoria di Carrie Lam. E gli arresti, ovviamente, non si sono fatti attendere.
La visita di Xi
Per Xi Jinping è stata la prima visita ad Hong Kong da quando è salito al potere: il presidente è apparso determinato nel difendere – se non promuovere – il sentimento di unione che vi è tra Pechino e l’ex colonia britannica. Durante una breve conferenza stampa tenutasi nella pista dell’aeroporto, Xi ha elencato le motivazioni della sua visita, finalizzata a mostrare la presenza concreta e solidale del governo cinese nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, definendone il futuro politico ed economico nel rispetto della formula “un Paese, due sistemi”, come sancito dalla Hong Kong Basic Law.
Ad anticipare le intenzioni di sinizzazione dell’hub finanziario è stato il
Global Times, la costola del Quotidiano del Popolo, che ha sottolineato il ruolo di “super connettore” che Hong Kong può avere nello sviluppo e nel successo della
Belt and Road Initiative, la
Nuova Via della Seta. E di certo non sarà passato inosservato il nuovo gioiello del
soft power cinese: un
video realizzato dall’agenzia di stampa Xinhua che celebra, in chiave rap, il successo del sistema “un Paese, due sistemi”.
Il prosieguo della visita del presidente ha fornito l’occasione per mostrare i muscoli della macchina militare cinese e, forse, per intimidire i moti indipendentisti dell’ex colonia britannica: Xi ha visitato la base militare di Shek Kong (nelle vicinanze di Shenzhen) e ha risposto al saluto delle 3.1000 truppe dell’Esercito popolare di liberazione con un “Salve, compagni!”, mentre sfilava su una jeep scoperta.
Contemporaneamente, i media raccontavano anche del breve arresto degli esponenti della League of Social Democrats e del partito Demosisto (erede del movimento degli ombrelli), tra cui Joshua Wong, per aver manifestato la sera prima davanti alla Golden Bauhinia Statue, la statua d’oro che raffigura l’orchidea simbolo di Hong Kong (che proprio Pechino aveva regalato alla città dopo il ritorno alla madrepatria).
La strategia di Carrie Lam
La cerimonia di insediamento della nuova chief executive, organizzata non a caso nella giornata della celebrazione del ventennale del trasferimento della sovranità da Londra a Pechino, ha visto il passaggio di testimone dal governatore uscente Leung Chun-ying, elogiato da Xi per la gestione dei tumulti studenteschi del 2014, a Carrie Lam.
In un abito dalla foggia cinese, Carrie Lam ha illustrato, sotto gli occhi di Xi Jinping, il suo manifesto politico nel tentativo di arginare la rottura che si è creata tra la popolazione, in particolare la fascia più giovane, e l’establishment. La Lam ha invitato ad entrare a far parte della nuova squadra di governo ciascun rappresentante politico interessato a risolvere i problemi strutturali della città, a prescindere dallo schieramento. Il rapporto con Pechino e i moti indipendentisti passano in secondo piano se si considerano le problematiche che nel quotidiano affliggono gli hongkonghesi: la speculazione immobiliare, l’incremento della disoccupazione giovanile, la perdita del primato fiscale e commerciale, solo per citarne alcuni.
Dopo il giuramento della leader della Regione amministrativa speciale, il presidente cinese, nel suo discorso, ha fugato ogni dubbio sull’approccio di Pechino alla questione di Hong Kong, sottolineando la necessità di rafforzare il sistema educativo e scolastico attraverso lo studio e la comprensione della Basic Law e degli elementi culturali e storici nazionali. Xi ha sottolineato che le sfide allo status quo di Hong Kong non saranno tollerate e che qualsiasi azione che possa mettere in pericolo la sovranità e la stabilità della Cina sarà considerata “assolutamente inammissibile”.
L’ex colonia nella morsa cinese
Hong Kong non è più l’oca d’oro del secolo scorso, quando Margaret Thatcher e Zhao Ziyang firmarono, nel 1984, la Dichiarazione congiunta sino-britannica, decretando il passaggio dalla sovranità britannica a quella cinese secondo la formula “un Paese, due sistemi”, nel 1997.
Allora il potere economico dell’hub finanziario avrebbe garantito la realizzazione delle riforme economiche di Deng Xiaoping. Un quadro che è tuttavia cambiato: se nel 1997 il Pil hongkonghese costituiva il 18,5% di quello cinese, attualmente ne rappresenta circa il 2,9%. La Regione amministrativa speciale dipende prevalentemente dalla Cina continentale per l’approvvigionamento alimentare, mentre l’80% della spesa turistica proviene dalle tasche dei cinesi della terraferma.
Le preoccupazioni di una prevaricazione di Pechino culminano nelle incertezze sulla vitalità di Hong Kong come centro finanziario e commerciale. Nel decennio scorso, ad esempio, il terminal container di Hong Kong era il più importante ed attivo al mondo; ora, il porto ha perso il suo primato mondiale, scendendo al quinto posto della classifica, dietro Shanghai, Singapore, Shenzhen e Ningbo.
I duri colpi inflitti all’economia della metropoli asiatica e la graduale erosione dei diritti civili portano Hong Kong sotto il cappello politico del Partito comunista cinese. Forse è proprio questo il successo della formula “un Paese, due sistemi” celebrata dal presidente Xi, tanto che le immagini delle gloriose proteste sotto gli ombrelli gialli sembrano già materiale d’archivio.